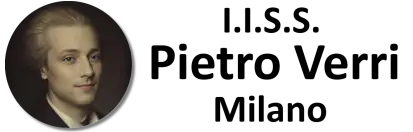Strasburgo 25/2-1/3/2024
L’UNIONE EUROPEA TRA ASPIRAZIONE E REALTA’
Un po’ di storia
L’Unione Europea, pur nascendo ufficialmente nel 1993 con il Trattato di Maastricht, affonda le sue radici in un terreno fertile di idee e ideali già sviluppati decenni prima.
Tra questi, un ruolo fondamentale ha avuto “Il Manifesto per un’Europa libera e unita”, noto come Manifesto di Ventotene, redatto nel 1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, antifascisti mandati al confino sull’isola di Ventotene dal regime dittatoriale di Benito Mussolini per evitare che diffondessero il dissenso.
Il Manifesto è il frutto di riflessioni sulla cosiddetta “guerra dei 30 anni” che dal 1914 al 1945 ha sconvolto l’Europa e le cui cause vengono individuate nel conflitto tra i Paesi europei per l’affermazione della propria egemonia sugli altri.
E’ sulle macerie del secondo conflitto mondiale, in una situazione di profonda depressione economica, politica e spirituale che prende corpo l’idea del superamento delle antiche divisioni tra gli Stati europei in vista della loro integrazione in una struttura politica superiore.
Il Manifesto, pur in un contesto storico drammatico, ha gettato le basi per un’Europa unita e federale, libera dalla minaccia di future guerre e regimi totalitari, proponendo la creazione di una “Federazione Europea” ispirata ai principi di pace e di libertà, con base democratica, dotata di un Parlamento e di un Governo cui affidare ampi poteri in materia di difesa, economia e politica estera.
Erano state così poste le basi teoriche per l’unificazione europea.
I TRATTATI
Un primo passo concreto verso questa visione viene compiuto nel 1951 con la firma del Trattato di Parigi, che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA).
La CECA, antenata dell’odierna Unione Europea, mirava a creare un mercato comune per il carbone e l’acciaio, due settori chiave per la ricostruzione post-bellica, al fine di favorire la cooperazione economica tra i paesi membri (Francia, Germania, Italia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) e contribuire attraverso il mercato comune del carbone e dell’acciaio all’incremento dell’occupazione e al miglioramento del tenore di vita, oltre che prevenire nuovi conflitti.
La CECA rappresenta un’esperienza pionieristica di integrazione europea, dimostrando i benefici della cooperazione e ponendo le basi per un’unione più ampia e completa. Il Trattavo istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio ha anche una chiara valenza simbolica, oltre che economica, perché il carbone e l’acciaio da strumenti utilizzati per la fabbricazione di armamenti bellici, di cui gli Stati europei erano stati vittime, diventano un primo tassello della costruzione della federazione europea.
Con i Trattati di Roma del 1957 è nata l’EURATOM, con la missione principale di garantire la sicurezza degli impianti nucleari e controllare che l’energia nucleare non venga impiegata a scopi diversi da quelli civili, e la Comunità Economica Europea (CEE), che amplia la cooperazione economica a un ventaglio più ampio di settori e getta le basi per un mercato unico europeo, che si trasformerà successivamente nel 1992 con il Trattato di Maastricht.
Il Trattato di Maastricht istituisce l’Unione Europea (UE) e introduce la procedura di codecisione, che conferisce al Parlamento europeo maggiori poteri nel processo decisionale e nuove forme di cooperazione tra gli Stati membri in materia di difesa, giustizia, affari interni.
Programma l’introduzione di una moneta unica europea (euro) e istituisce la cittadinanza europea che conferisce ai cittadini dell’Unione il diritto di circolare e soggiornare liberamente in qualunque Paese dell’UE.
Ma è con il Trattato di Nizza del 2000 che l’Europa compie un salto di qualità.
Con il Trattato di Nizza viene istituita la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nota come Carta di Nizza che possiamo considerare il manifesto dei valori in cui l’Unione si riconosce e ai quali le istituzioni europee e le singole istituzioni degli Stati membri devono conformarsi.
Nella Carta di Nizza, spirito e anima del valori europei, viene sancito un complesso di diritti fondamentali articolato sui valori della dignità umana, di libertà, di democrazia, di uguaglianza, di solidarietà, divieto di discriminazioni, cittadinanza europea, giustizia, stato di diritto.
Valori importanti, faticosamente emersi dalla barbarie, dalle guerre, dai totalitarismi e dalle persecuzioni del “900, oggi nuovamente messi a dura prova da Stati autoritari, autocrazie e populismi di vario genere, purtroppo anche all’interno della stessa Unione Europea.
Ciascun cittadino dell’Unione Europea che ritenga che tali diritti siano stati lesi potrà chiederne la tutela innanzi ad una importantissima istituzione, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nota come CEDU, organo giurisdizionale che, pur non essendo un’istituzione propria dell’Unione Europea, è posta comunque a presidio e salvaguardia dei diritti previsti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Il Trattato di Lisbona, sottoscritto nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009, rappresenta l’ultima grande revisione dei trattati europei. Introduce importanti modifiche al funzionamento dell’Unione, ulteriormente rafforzando il ruolo del Parlamento europeo e rendendo le istituzioni più democratiche e trasparenti.
Inoltre, il Trattato di Lisbona, assegna alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea un valore giuridico, quindi vincolante per gli Stati membri, oltre che morale, ampliando e rafforzando la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini europei, garantendo loro una protezione più ampia e completa.
IL NOSTRO VIAGGIO DI ISTRUZIONE
Noi abbiamo avuto la fortuna di visitare i luoghi “immaginati” nel Manifesto di Ventotene, vivendo appieno lo “spirito europeo”.
Durante il nostro viaggio di istruzione abbiamo potuto osservare il Luogo dove l’idea di democrazia diventa concreta, il Parlamento Europeo, sede di Strasburgo, città a lungo contesa tra Francia e Germania e quindi emblema di riconciliazione e pacificazione tra i popoli, eletta per questo a simbolo della costruzione europea.
Dopo il grande impegno organizzativo delle nostre professoresse, siamo riusciti ad assistere a una sessione plenaria del Parlamento Europeo, durante la quale abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare la Relazione Annuale della Banca Centrale Europea presentata dalla Presidente Christine Lagarde, sentendoci molto più partecipi di un meccanismo che siamo abituati a vedere solo da lontano e le cui decisioni hanno tanta influenza nelle nostre vite.
La Presidente della BCE ha illustrato al Parlamento gli effetti positivi dell’innalzamento dei tassi di interesse sul contenimento dell’inflazione nei Paesi dell’Eurozona.
Durante il resto del nostro viaggio abbiamo inoltre visitato Bruxelles e abbiamo avuto la possibilità di approfondire questo “sentimento di Europa” che avevamo annusato a Strasburgo, visitando il “quartiere europeo”, ovvero il quartiere dove hanno sede tutte le principali istituzioni europee, come la Commissione Europea (rappresenta l’organo10 esecutivo ed è composto da commissari che vengono scelti dai rispettivi governi nazionali); il Consiglio dell’Unione Europea (insieme al Parlamento è il principale organo decisionale; in esso sono rappresentati i governi dei singoli Stati i quali intervengono attraverso un proprio ministro, a seconda della materia in cui occorre legiferare); il Consiglio Europeo (rappresentato dai capi di Stato e di Governo che ha il compito di adottare strategie comuni su grandi temi comuni quali immigrazione; politica estera; criminalità organizzata; infrastrutture, rispetto dello stato di diritto) nonché l’altra sede del Parlamento Europeo.
L’Unione Europea oggi: criticità e sfide per il futuro
Questa vicinanza alle istituzioni europee, ci ha aiutato ad ampliare il nostro pensiero e sviluppare uno spirito critico a riguardo. Non sono dunque mancate riflessioni rispetto i punti deboli dell’Unione, tra cui sono spiccati:
● una grande burocrazia che disincentiva l’adesione alle iniziative e rende complicata la comprensione di nuove direttive e regolamenti al normale cittadino che ne subisce gli effetti;
● un deficit democratico: eccezion fatta per il Parlamento Europeo eletto direttamente dai cittadini dell’Unione a cadenza quinquennale (il prossimo 9 e 10 giugno si voterà per il nuovo Parlamento Europeo), mancano istituzioni rappresentative del “popolo europeo” essendo le altre istituzioni rappresentative dei singoli governi nazionali i cui egoismi particolari spesso prevalgono sugli interessi comunitari;
● l’estrema complessità del funzionamento degli organi europei, i quali hanno competenze miste e frazionate, senza un chiaro schema di separazione dei poteri tra legislativo ed esecutivo, la necessità di continue mediazioni politiche per evitare che i singoli stati esercitino il proprio “veto” per quanto riguarda l’approvazione di leggi che richiedono l’unanimità, ecc..
● la mancanza di una politica europea per quanto riguarda la materia fiscale e di difesa: la prima impedisce la creazione di un mercato equo e competitivo, in quanto le imprese presenti su Stati con una legislazione fiscale più leggera avranno un vantaggio competitivo sulle imprese localizzate in Stati con una legislazione fiscale pressante; la seconda impedisce all’Europa di intervenire in zone di crisi, come forza di pace, per far valere il rispetto dei diritti stabiliti nella Carta di Nizza. L’Europa deve inoltre poter difendere i valori che le sono cari anche dotandosi di un difesa comune.
Segnali di una svolta nel senso di una maggiore solidarietà europea si sono avuti con il Recovery Found, uno strumento creato dall’UE per aiutare economicamente i Paesi più colpiti dall’epidemia da Covid19 e finanziato con l’emissione di Recovery bond, cioè obbligazioni europee e quindi debiti contratti da tutta l’Unione e non dai singoli Stati beneficiari.
I singoli Paesi dovranno elaborare un piano per utilizzare questi fondi secondo le linee guida impartite dall’Unione Europea privilegiando la transizione ecologica e digitale. C’è da augurarsi che non vengano dispersi in clientelismi e per finanziare interventi assistenzialistici e spesa corrente.
Oggi l’Unione Europea si trova a un bivio cruciale della sua storia; deve affrontare grandi sfide sia al proprio interno sia sulla scena globale.
La guerra in Ucraina, i conflitti in Medio Oriente, la gestione dei flussi migratori, la difesa del welfare state, sono tutte sfide che devono essere affrontate se l’Unione Europea ambisce a giocare un ruolo da protagonista sulla scena mondiale e se vuole continuare a essere un presidio di democrazia e di tutela dei diritti fondamentali che non sono scontati ma richiedono continui investimenti in termini di attenzione alla loro difesa da attacchi che vorrebbero ridurne la portata o sopprimerli.
Nonostante le criticità, considerato il panorama mondiale, la nostra Europa è ancora un simbolo di pace, di prosperità, di democrazia, di libertà. Il posto migliore in cui nascere e vivere.
Classe V SIA – Curatrice Prof.ssa Rosa Carvelli